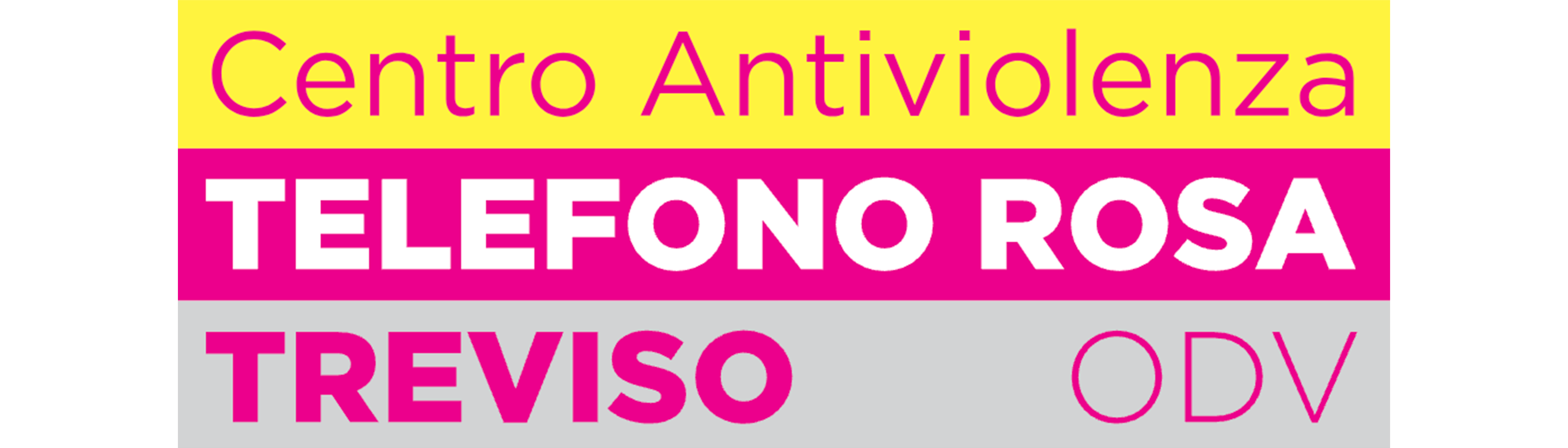Le reazioni molto accese alle motivazioni della sentenza Turetta sollevano una domanda; perché chiediamo al diritto penale di risolvere problemi di ordine culturale?
Da qualche giorno, complice la pubblicazione delle motivazioni della sentenza di primo grado che condanna Filippo Turetta all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Cecchettin, il dibattito pubblico sul femminicidio si è riattivato, replicando quanto già avvenuto a dicembre, al momento della pronuncia della condanna.
Scrivo queste riflessioni sapendo quanto sia scivoloso e delicato entrare con strumenti analitici in un dibattito che è – inevitabilmente – costruito soprattutto sulle emozioni. Le scrivo da femminista, da femminista garantista, e non si tratta di dichiarare un posizionamento per poi demolirlo, ma di credere che sia un binomio possibile e sempre più necessario, soprattutto oggi.
Proprio perché questa storia è una storia in corso, che riguarda famiglie e persone che attraversano un lutto profondo, vorrei innanzitutto scusarmi se le mie parole possano apparire inopportune, o in contrasto con la legittima posizione di chi è direttamente coinvolto. Ma dato che il personale è politico, e che le storie possono essere paradigma, credo che sia importante attingere a quei saperi che ci aiutano a trovare la rotta, quando il mare è in tempesta.
Suddividerò pertanto il ragionamento in quattro livelli: quello giuridico, quello culturale, quello politico, quello della lotta.
Il piano giuridico
Turetta, reo confesso dell’omicidio della sua ex fidanzata Giulia, è stato condannato alla pena massima prevista, ossia l’ergastolo. Tuttavia, i giudici del primo grado hanno deciso di non riconoscere due aggravanti richieste dall’accusa: lo stalking come aggravante di continuazione di un altro reato e la crudeltà. Se a dicembre era stata l’aggravante di stalking a scatenare un putiferio in quanto non riconosciuta nonostante l’enorme mole di messaggi e le manie di controllo proposte dall’ex fidanzato, ora il flame mediatico si è attivato su una piccola porzione delle motivazioni che riguardano l’aggravante della crudeltà.
La prima aggravante era caduta perché la pratica culturale dello stalking, ossia gli atti persecutori, non si configurava nel caso specifico come premessa criminosa dell’omicidio, ovvero in termini di causa-effetto processuale, l’omicidio non è l’effetto dello stalking e della denuncia di stalking. La giurisprudenza distingue il reato per sé di stalking (che non c’era perché è reato a querela di parte, ossia solo Giulia poteva chiedere di procedere e Giulia non solo non aveva denunciato Filippo Turetta, ma continuava a sentirlo) dall’aggravante, ossia l’omicidio che avviene come climax dello stalking pregresso. In termini processuali, non si sono verificate quelle condizioni.
Ma è il tema della crudeltà, soprattutto, ad aver suscitato un’intensa polarizzazione nel dibattito pubblico. La decisione dei giudici – di primo grado – è importante ricordarlo in un sistema che prevede tre livelli di giudizio – si basa su una giurisprudenza ormai consolidata, che stralcia la crudeltà come aggravante e la riconduce a conseguenza della inesperienza e della inabilità. I giudici, nei fatti, dicono che la crudeltà come fatto a sé non c’è, Turetta non voleva essere crudele, ma ucciderla in modo efferato, e aggiungono che tale efferatezza è stata anche dettata dall’inesperienza e inabilità.
In particolare, la sentenza della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione del 2015 e un’altra del 2016 chiariscono come debba essere interpretata, in sede processuale, l’aggravante della crudeltà (art. 61 n. 4 c.p.). In sintesi, perché si verifichi l’aggravante della crudeltà richiede un effettivo superamento della “normalità causale” del reato: occorre una volontà ulteriore di infliggere sofferenze gratuite e inutili alla vittima, oltre a quelle già insite nell’atto omicidiario. In altre parole, si tratta di azioni aggiuntive, non necessarie o sconnesse in chiave logica dalla volontà di uccidere. Per la giurisprudenza, perciò il mero numero dei colpi (75) non è sufficiente a configurare la crudeltà se non è accompagnato da una volontà efferata autonoma. La corte afferma che non esiste un limite numerico fisso di colpi oltre il quale scatta automaticamente l’aggravante: va valutata la modalità complessiva dell’azione e l’intenzionalità soggettiva. Il principio del “ne bis in idem” vieta che lo stesso fatto venga punito due volte, anche come aggravante. In questo caso, non si può punire due volte l’atto omicidiario. Neppure l’abbandono della vittima agonizzante costituisce necessariamente crudeltà, se coerente con l’intento omicida.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che né il numero di colpi né l’abbandono della vittima costituissero elementi sufficienti, in assenza di una chiara volontà di infliggere sofferenze ulteriori. Preme inoltre ricordare che anche se fossero state riconosciute, tali aggravanti non avrebbero in alcun modo alterato la condanna, che aveva già previsto la pena massima possibile, e negato tutte le attenuanti generiche e specifiche richieste dalla difesa.
Il piano culturale
In questo contesto, le parole usate in questi anni da Elena Cecchettin, sorella della vittima, hanno assunto un peso importante per la lucidità con cui ha indicato la radice sistemica del femminicidio. In una lettera inviata a novembre 2023 al «Corriere della Sera», scriveva: “Il femminicidio non è un delitto passionale, è un delitto di potere. Serve un’educazione sessuale e affettiva capillare, serve insegnare che l’amore non è possesso. Bisogna finanziare i centri antiviolenza e dare la possibilità di chiedere aiuto a chi ne ha bisogno. Per Giulia non fate un minuto di silenzio, per Giulia bruciate tutto.”
Una voce politica, puntuale, che denuncia la continuità tra controllo, manipolazione, colpevolizzazione e omicidio.
Ma a fianco di questa denuncia, Elena ha anche criticato l’assenza di riconoscimento delle aggravanti: “Se non iniziamo a prendere sul serio la questione, tutto ciò che è stato detto su Giulia, che doveva essere l’ultima, sono solo parole al vento […] si, fa la differenza riconoscere le attenuanti, perché vuol dire che la violenza di genere non è presente solo dove è presente il coltello o il pugno. Ma molto prima. E significa che abbiamo tempo per prevenire gli esiti peggiori. Sapete cosa ha ucciso mia sorella? Non solo una mano violenta, ma la giustificazione e il menefreghismo per gli stadi di violenza che anticipano il femminicidio”.
“Scrivo queste riflessioni sapendo quanto sia scivoloso e delicato entrare con strumenti analitici in un dibattito che è – inevitabilmente – costruito soprattutto sulle emozioni. Le scrivo da femminista, da femminista garantista, e non si tratta di dichiarare un posizionamento per poi demolirlo”.
È questo, probabilmente, il nodo più complicato della questione: l’intersezione fra la legittima richiesta di giustizia e la necessaria tenuta garantista del sistema penale. La vicenda di Giulia è diventata emblematica e ogni elemento processuale è stato caricato di significati collettivi. Ma è legittimo chiedere a una sentenza – per sua natura tecnica e circoscritta – di svolgere una funzione pedagogica o simbolica?
La sentenza ha infatti un passaggio interessante proprio in termini culturali, riconoscendo le strutture simboliche come la ragione, il “motivo abietto” che motiva il gesto. Si legge infatti: “l’efferatezza dell’azione, della risolutezza del gesto compiuto e degli abietti motivi di arcaica sopraffazione che tale gesto hanno generato: motivi vili e spregevoli, dettati da intolleranza per la libertà di autodeterminazione della giovane donna, di cui l’imputato non accettava l’autonomia delle anche più banali scelte di vita”.
Tuttavia, il passaggio culturale sul patriarcato inteso come sistema simbolico e culturale che genera “l’arcaica sopraffazione”, e “l’intolleranza per la libertà di autodeterminazione della giovane donna” non è sufficiente per rispondere alla domanda di giustizia, che si traduce nel dibattito pubblico in una richiesta di pena come un meccanismo quasi vendicatorio.
Ma resta aperta la domanda: quale poteva essere una sentenza “giusta”? Cosa la rende “giusta” (e per chi)? E quali sono i reali ed efficaci strumenti di contrasto della violenza che oggi hanno a disposizione le donne?
Credo che questa sia il punto di caduta tra la legittima domanda di giustizia nei confronti della violenza di genere e il garantismo che dovrebbe accompagnare ogni provvedimento penale.
La vicenda di Giulia Cecchettin è divenuta simbolo della violenza di genere, più di casi che l’hanno preceduta o seguita (non ultime Ilaria Sula e Sara Campanella, le due ragazze uccise la settimana scorsa) e ogni aspetto processuale, proprio perché il caso è diventato emblematico, viene caricato di significati sociali e politici profondi. Il confronto si è esteso dai social ai luoghi del quotidiano, dal bar alla strada, alimentando un senso di urgenza interpretativa.
Credo che il compito del giudice debba limitarsi alla prima dimensione: il processo. Questo non per tutelare Filippo Turetta, ma per difendere lo stato di diritto e la tenuta emotiva, ossia la riprovazione sociale collettiva. La riflessione di Gino Cecchettin, padre di Giulia, è qui fondamentale. Nel suo ruolo pubblico ha condiviso il proprio dolore trasformandolo in una voce collettiva, ha scelto di canalizzare il proprio lutto in un progetto culturale e politico esemplare. E ha espresso una verità importante: la sentenza può offrire una pacificazione sociale, ma non necessariamente una ricomposizione del trauma. Per questo non deve essere per forza simbolica o pedagogica.
È una domanda legittima, politica, e importante: ci obbliga a riflettere su quali strumenti culturali, giuridici ed emotivi disponiamo oggi per affrontare la violenza di genere e soprattutto gli omicidi delle donne e delle ragazze e delle persone transgender da parte dei partner o ex partner. Per comprendere a fondo il concetto di crudeltà, può essere utile tornare all’etimologia. La parola deriva dal latino crudelitas, che a sua volta viene da crudelis, cioè ‘spietato’, ‘insensibile alla sofferenza altrui’. Ma ancor prima c’è la radice crudus, che significa ‘crudo’, ‘non cotto’, ‘acerbo’.
Originariamente riferita alla carne non cucinata, questa parola evoca qualcosa di viscerale, immediato, non trasformato – e, per estensione, socialmente inaccettabile. La crudeltà, quindi, è ciò che non è stato attraversato dalla cultura, dalla pietà, dall’empatia. È ciò che resta “vivo” e sanguinante, e che fa male perché non è stato né digerito né elaborato. È un rifiuto della trasformazione simbolica, la cui portata è stata ampiamente indagata nel corso della storia del pensiero e delle arti. Come scrive Hannah Arendt, la crudeltà nasce anche dall’incapacità di pensare l’altro come soggetto. Per Foucault, si inscrive nei dispositivi punitivi arcaici, nei corpi martoriati dal potere. In Shakespeare, è tensione tra istinto e parola, tra sangue e coscienza: Lady Macbeth che invoca gli spiriti per diventare crudele è emblema di questa metamorfosi. Nel suo fondo più oscuro, la crudeltà è disumanizzazione. È l’assenza di passaggio dal dolore al significato, dalla ferita alla cura. E’ interessante come, in un certo senso,il garantismo sia nato come risposta e antidoto alla crudeltà vendicatoria dello Stato e dei privati cittadini. Il garantismo è un concetto giuridico e politico che si riferisce alla tutela dei diritti fondamentali dell’individuo, in particolare dell’imputato nel processo penale, ma anche più in generale di chiunque sia soggetto al potere pubblico. È una concezione che pone al centro la difesa delle libertà individuali, il principio di legalità, la presunzione d’innocenza, e l’equilibrio tra poteri dello Stato. In senso più ampio, il garantismo è una cultura politica e giuridica che si oppone all’arbitrio, alla giustizia sommaria e alla repressione priva di tutele e va distinto dalle retoriche politiche che lo usano come sinonimo di impunità.
Il piano politico
Oggi siamo di fronte a una costante spinta verso quello che Milly Virgilio in un recente testo ha chiamato il “cattivismo legislativo”. Uno degli esempi più recenti in tal senso, è il disegno di legge promosso dall’attuale governo l’8 marzo, che istituisce il reato di “femminicidio”. Il fulcro qui è la previsione dell’ergastolo per chiunque (soggetto neutro) uccide “una donna”. Tale previsione è ammantata da un senso di ‘innovazione linguistico/normativa, poiché per la prima volta nella legge penale si introduce il lemma “femminicidio”.
Come ha scritto Virgilio, Il piano penale simbolico non produce alcun effetto deterrente, come affermato e dimostrato da tempo dalla dottrina penalistica più autorevole, anche a livello internazionale. Tuttavia, l’iniziativa del governo assume un valore strumentale: serve a distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica da questioni realmente urgenti e dalle derive antidemocratiche in atto, orientando il dibattito verso temi di facciata. Si tratta di una forma di attivismo solo apparente che, rafforzando dinamiche securitarie già operative da tempo, introduce nuove fattispecie di reato – spesso formulate in modo approssimativo e successivamente corrette in modo altrettanto impreciso – , inasprisce le pene, amplia le aggravanti e riduce i margini di valutazione tra circostanze attenuanti e aggravanti. Queste misure eccezionali nel campo del diritto penale alimentano un desiderio di punizione estrema, incarnato nell’idea del carcere “senza chiave”, presentata come soluzione definitiva ma applicata, in realtà, soltanto a chi osa mettere in discussione l’ordine politico ed economico dominante o ne compromette la facciata di rispettabilità.
In tal senso, si può leggere l’indignazione per una sentenza che condanna con pena massima l’autore di reato, invocando le aggravanti (che non avrebbero, anche volendo, potuto aumentare la pena).
Quello che forse ci interessa da una prospettiva sociologica (ma anche femminista) è capire che cosa è mancato nel dibattito pubblico, e forse nella trasmissione dal piano giuridico al senso comune, ma soprattutto perché stiamo chiedendo al diritto penale di dare un senso a un fenomeno come quello della violenza di genere. Non è questa la strada giusta da imboccare. La pronuncia della corte serve a determinare la responsabilità individuale di Filippo Turetta sul fatto concreto, ma tutto il resto è un lavoro politico culturale che non si può delegare al diritto penale
“È questo, probabilmente, il nodo più complicato della questione: l’intersezione fra la legittima richiesta di giustizia e la necessaria tenuta garantista del sistema penale”.
Il diritto penale è uno strumento preciso, regolato da garanzie formali, nato per limitare l’arbitrio. Il suo compito non è offrire risposte consolatorie, ma definire responsabilità individuali. È da questa tensione tra dolore, simbolo e diritto che nasce l’indignazione per una sentenza che infligge già la pena massima, ma non sembra “sufficiente” dal punto di vista simbolico. Tuttavia, il diritto penale ha limiti precisi. Serve a stabilire responsabilità, non a costruire pedagogie collettive. E se chiediamo al processo penale di colmare il vuoto culturale e politico della società, finiamo per confondere il ruolo del tribunale con quello della coscienza pubblica.
Il piano della lotta.
Cosa significa vittima? In che modo il termine può essere declinato? Come i movimenti politici che dovrebbero tendere alla liberazione dallo sfruttamento e dall’oppressione scelgono lo strumento punitivo come risposta e una pratica di liberazione?
In particolare il femminismo – inteso sia come sguardo, sia come postura, sia come posizionamento – diventa la chiave per decostruire i discorsi e le richieste che vengono mosse oggi al diritto penale. Un vero femminismo non può sposare la dimensione punitiva, o non può sposare solo quella dimensione, perché quella modalità dicotomica riporta spesso le donne in una condizione – ancora una volta – di vulnerabilità.
Ma chi è davvero la vittima? Un aiuto interessante ci viene dal lavoro della giurista e sociologa Tamar Pitch, che nel Malinteso della vittima analizza in profondità la costruzione dello status vittimario, mostrando come questo abbia progressivamente sostituito la precedente centralità dell’oppressione. Mentre la condizione di oppressione ha spesso una dimensione collettiva e attiva dinamiche sociali complesse, la vittima, al contrario, è sempre rappresentata come un soggetto individuale, come se questa singolarità fosse l’unico modo per far sentire la propria voce.
Pitch osserva anche che, nel momento in cui lo status di vittima acquista un valore riconosciuto e ambìto, emergono tensioni e competizioni per definirne i confini. Il ruolo della vittima assume quindi una valenza morale, fondata sull’idea di purezza e innocenza contrapposta a qualsiasi forma, anche indiretta, di responsabilità per ciò che è accaduto. È proprio questo, secondo Pitch, il “paradosso vittimario”, capace di neutralizzare gran parte dello spazio tradizionalmente riservato alla dimensione politica.
Essere vittime, però, significa ancora una volta non essere libere e non autodeterminarsi. I meccanismi contraddittori della vittimizzazione possono, paradossalmente, contribuire a riprodurre le stesse strutture di potere che pretendono di denunciare. È infatti immediato associare la donna vittima all’idea di protezione – spesso maschile – che ne deriverebbe.
Questi processi sono ulteriormente complicati, oggi, dall’emergere di tendenze individualistiche anche all’interno del femminismo. A tal proposito, Pitch sottolinea come oggi la “nostra” soggettività politica si costruisce attraverso la definizione delle “altre” come vittime, con la conseguenza che “noi” parliamo e le “altre”, le “vittime”, sono ridotte al silenzio.
Questa dinamica si intensifica in un contesto in cui la soggettività politica si costruisce spesso per esclusione, e la vittima – sempre “altra” – diventa il fulcro di nuove forme di controllo e paternalismo.
Il femminicidio di Giulia Cecchettin ha toccato corde profonde e ha aperto una ferita che ci include, o include molte e molti di noi. Ma la domanda che dobbiamo porci, come società e come movimenti, è se davvero vogliamo affidare al diritto penale – e solo a esso – il compito di curare quella ferita. La giustizia penale può punire, ma non può educare, né trasformare i codici culturali dell’amore, del possesso, della sopraffazione. Quel lavoro è politico, simbolico, educativo. Ed è lì che dobbiamo concentrare i nostri sforzi.
Solo in tempi recenti i femminicidi sono stati riconosciuti pubblicamente come espressione di una violenza strutturale e sistemica, inserita in un contesto politico più ampio grazie anche a voci come quella di Elena Cecchettin. Mai come in questo caso, il discorso femminista ha varcato i confini del proprio spazio politico per incontrare una sensibilità più ampia, raggiungendo donne, giovani e, finalmente, anche molti uomini. Ma è stato un processo culturale, e non era necessario un nuovo reato per questa trasformazione.
La storia legislativa italiana sul tema mostra chiaramente i suoi limiti: in più di cinquant’anni si sono susseguiti interventi normativi che, seppur numerosi, non hanno inciso sulla realtà materiale della violenza. Nonostante leggi come quella sul reato di stalking, sul “codice rosso” o il ddl “femminicidio”, i numeri non cambiano. L’efficacia simbolica ha spesso sostituito quella reale.
Il corpo delle donne rimane “un luogo pubblico”. Oggi il diritto viene brandito come arma apotropaica, come soluzione, come strumento (prima mediatico, poi di efficacia giuridica) nelle aule. Rita Laura Segato, scrittrice e attivista argentina, parla addirittura di “diritto come incantesimo”. Si evoca la magia di uno strumento che tuttavia non solo non è mai risolutivo, ma spesso è aderente alle stesse logiche che si vogliono combattere. L’illusione è che la legge possa educare o riparare, quando invece essa nasce – storicamente – proprio da un asimmetrico rapporto di potere.
Più che nuove leggi, servirebbero nuovi spazi di cultura, socialità e politica, capaci di rigenerare il significato dei diritti.
Il vero cambiamento, allora, si gioca su un piano culturale. Solo rivendicando diritti molteplici – di genere, identità, classe, cittadinanza – si può contrastare la violenza alla radice. Solo rafforzando la protezione sociale e promuovendo pratiche di empowerment si possono riequilibrare i poteri storicamente distorti. La lotta contro la violenza di genere deve diventare una lotta contro tutte le diseguaglianze, e quindi un progetto politico condiviso, non solo delle donne, ma di tutti.
La sfida, però, è anche epistemica: come decostruire il linguaggio, i simboli e le parole che hanno veicolato per secoli il dominio patriarcale? Per liberarsi le parole vanno studiate, e pulite. Pulite dal mandato di mascolinità. Pulite da un sapere che umilia e gerarchizza le soggettività. Pulite dal monopolio legittimo della moralità. Liberando il desiderio, i desideri, le strade, le notti. Non si tratta solo di riscrivere il diritto, ma di reinventare l’immaginario.
“Solo rafforzando la protezione sociale e promuovendo pratiche di empowerment si possono riequilibrare i poteri storicamente distorti. La lotta contro la violenza di genere deve diventare una lotta contro tutte le diseguaglianze, e quindi un progetto politico condiviso, non solo delle donne, ma di tutti”.
Questa trasformazione non può essere compito esclusivo delle donne. La battaglia è di genere, l’ultima parola spetta a loro, ma come suggerisce Rita Segato la soluzione sta nella reciprocità, perché ci radica, ci posiziona e mette in relazione in modo concreto. E perché non si può essere davvero libere se sottoposte al perenne sguardo disciplinante.
Il femminismo ha da sempre insegnato a partire da sé, ma oggi occorre partire da un “noi”. Allargare la soggettività politica, costruire nuove pratiche di libertà, generare desideri, essere vive.
Valeria Verdolini è ricercatrice universitaria, sociologa, attivista e presidente di “Antigone Lombardia”.